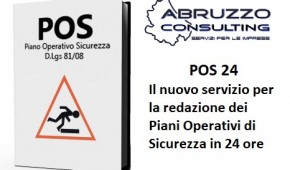Cassazione Penale – Lavoratore precipita dal tetto di un capannone. Responsabilità del committente per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria
 Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19036 – Lavoratore precipita dal tetto di un capannone. Responsabilità del committente per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria.
Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19036 – Lavoratore precipita dal tetto di un capannone. Responsabilità del committente per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria.
Fatto:
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 20/05/2016, ha riformato la sentenza del Tribunale di quella città in data 18/07/2013, appellata dall’imputato R.G. e dal Procuratore Generale, dichiarando C.F., assolto in primo grado, responsabile del reato ascritto, condannandolo a pena sospesa, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con provvisionale in solido con l’imputato R.G., del quale ha rigettato integralmente il gravame.
Si è contestato agli imputati il reato di cui agli artt. 40 cpv. 110 e 589 co. 2 cod. pen., per avere, unitamente a R.E., giudicato separatamente: C.F., quale committente dei lavori di rifacimento del tetto di un capannone di proprietà, commissionati alla COMAED s.r.l., violato l’art. 7 co. 2 lett. a) e co. 3 del d.lgs. 626/947 e successive modifiche, non cooperando con l’impresa appaltatrice per attuare le misure di prevenzione dei rischi sul lavoro; R.G., quale socio della COMAED s.r.l. e coordinatore di fatto delle opere oggetto dell’appalto, omesso di adottare le prescritte misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro (installazione di impalcatura, di ponteggio o opera provvisionale al fine di eliminare il pericolo di caduta dall’alto – art. 16 d.P.R. 164/56), di dotare il lavoratore B.A. della cintura di sicurezza con bretelle collegate ad una fune di trattenuta (art. 10 d.P.R. 164/56), di fornire al predetto le informazioni dovute e assicurargli una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute nel luoghi di lavoro (art. 22 co. 1 e 5 d.P.R. 626/94), non impedendo in tal modo che il lavoratore precipitasse dal tetto del capannone da un’altezza di 5 metri circa, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionando così la morte del predetto lavoratore B.A. (in Adrano accertato il 06/12/2003).
2. Questa in sintesi la vicenda.
La sentenza impugnata ha ad oggetto l’infortunio sul lavoro verificatosi presso un cantiere edile in cui erano in corso lavori di rifacimento del tetto di un capannone industriale adibito ad officina meccanica di proprietà del committente C.F.. Sui luoghi, il 06/12/2003 veniva infatti rinvenuto il cadavere del B.A., precipitato da circa 5 metri di altezza, mentre era intento a lavorare sul tetto del predetto capannone.
L’istruttoria ha acclarato che l’infortunio era stato conseguenza dell’omesso utilizzo di impalcature, ponteggi o opere provvisionali, idonee ad evitare il pericolo di cadute dall’alto, nonché del mancato uso di cintura con bretelle collegate a fune trattenuta (in tal senso, ricognizione esterna del cadavere, rilievi tecnici, riproduzioni fotografiche, deposizione ispettore del lavoro M., ispettore capo presso il Commissariato di A.N., testi S. e I..)
3. Il Tribunale ha ritenuto accertata l’esistenza di un contratto di appalto tra il committente C.F. e la società COMAED a r.l., avente ad oggetto non soltanto la fornitura dei pannelli coibentanti, ma anche la loro installazione, nonché un rapporto di lavoro di fatto tra la predetta COMAED s.r.l. e il lavoratore B.A., circostanze entrambe oggetto di accertamento in via definitiva nel processo a carico di R.E., A.U. COMAED s.r.l.
Quanto al R.G., il Tribunale catanese ne ha ritenuto la penale responsabilità, stante l’acclarato ruolo di gestore di fatto della ditta, nella quale non vi era ripartizione di ruoli tra i fratelli R.G., e coordinatore di fatto di quei lavori, gestiti e seguiti personalmente, avendo egli concordato con il committente l’esecuzione dell’appalto, ingaggiando il lavoratore B.A. per l’esecuzione dello smontaggio della preesistente copertura e il posizionamento dei nuovi pannelli, dando altresì ordine ad alcuni dipendenti della ditta di portare mezzi e materiali utili per l’esecuzione dell’opera e impartendo ordini allo stesso B.A..
Quel giudice ha, invece, assolto il committente dei lavori C.F., escludendone una ingerenza nella organizzazione del lavoro e non ravvisando in capo allo stesso una posizione di garanzia.
4. La Corte d’appello, confermata la condanna dell’Imputato R.G., ha ribaltato il verdetto assolutorio nei confronti dell’imputato C.F., ritenendo fondato il motivo di gravame articolato dal Procuratore Generale. In particolare, ha ritenuto esistente in capo al predetto una autonoma posizione di garanzia ed una colpevole omissione dei doveri di vigilanza da parte del committente, a fronte del rischio generico di caduta dall’alto.
5. L’imputato R.G. ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, rilevando, in via preliminare, che l’imputazione contestata è nata a seguito della trasmissione degli atti al P.M., ordinata dal primo decidente nel diverso procedimento a carico di R.E., legale rappresentante della COMAED s.r.l., avendo il giudice ritenuto che le risultanze processuali imponessero l’approfondimento della posizione degli odierni imputati, sia con riferimento all’esercizio del controllo diretto e della responsabilità del cantiere, che avuto riguardo alla necessità di accertare chi fosse il datore di lavoro del B.A. o avesse la responsabilità del cantiere, venendo meno all’obbligo di approntare le opportune misure antinfortunistiche, non senza osservare che, già alla luce della normativa vigente all’epoca dei fatti, sussisteva a carico del committente l’obbligo di collaborazione prevenzionale con l’appaltatore o il lavoratore autonomo imposto dall’art. 7 del d.lgs. 626/94, a prescindere dalla forma del contratto concluso dal committente.
Alla luce di tale premessa, la parte ha quindi formulato quattro, distinti motivi.
5.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la COMAED s.r.l. e la vittima, dovendo ritenersi che fu proprio il C.F. a decidere di avvalersi dell’opera di quest’ultimo, bracciante agricolo che aveva ricoverato la propria auto presso l’officina del primo per una riparazione e che il R.G. si era solo limitato a presentare al C.F..
Sotto altro profilo, si è evidenziata la contraddittorietà della decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto la penale responsabilità del R.G. per avere contemporaneamente assunto la qualità di datore di lavoro/amministratore di fatto della COMAED s.r.l. e coordinatore della esecuzione dell’appalto in un cantiere dove evidentemente si trovavano ad operare più imprese oppure un’impresa (la COMAED s.r.l.), per la fornitura dei pannelli ed un lavoratore autonomo (il B.A.) per il loro posizionamento. La Corte avrebbe inoltre travisato le prove testimoniali, avendo i testi S. e M., dipendenti della COMAED s.r.l., affermato unicamente di aver ricevuto l’ordine di trasportare il materiale edile al capannone e il teste M., ispettore del lavoro, affermato che il B.A. era un lavoratore autonomo, registrato come bracciante agricolo, altresì obliterando che nel giudizio del lavoro era stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la COMAED s.r.l. e il B.A., con sentenza allegata in copia al ricorso.
5.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento, questa volta, alla ritenuta esistenza di un contratto di appalto “chiavi in mano”, atteso che la presenza degli operai della COMAED s.r.l. nel cantiere era finalizzata unicamente alla consegna sul posto e, quindi, sul tetto, del materiale acquistato.
Anche sotto questo aspetto, si è dedotta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto esistenti in capo al R.G. sia la qualifica di amministratore di fatto della COMAED s.r.l., sottoscrittore del contratto di appalto, che quella di coordinatore di fatto dell’esecuzione dei lavori, in tal modo configurando in capo al medesimo la posizione soggettiva di controllore di se stesso.
5.3. Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi riprendendo le considerazioni già svolte con riferimento alla doppia qualifica di datore di lavoro e coordinatore dell’esecuzione dei lavori, esclusa dal dettato normativo, rilevando inoltre che la Corte d’appello avrebbe addebitato al R.G., quale coordinatore di fatto dell’esecuzione dell’opera, profili di colpa specifica propri del datore di lavoro. Sotto altro aspetto, si è poi rilevato che la Corte catanese avrebbe operato una inammissibile duplicazione della posizione di garanzia propria di quest’ultima figura, estendendola dall’amministratore R.E., già definitivamente giudicato, all’odierno imputato, al quale tuttavia non era stata conferita alcuna delega formale dal rappresentante legale della COMAED s.r.l.
5.4. Infine, con il quarto motivo, sono stati dedotti analoghi vizi, questa volta con riferimento al trattamento sanzionatolo, avendo il giudice d’appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma operato il bilanciamento in termini di sola equivalenza con le contestate aggravanti, giustificando in maniera illogica ed insufficiente la scelta operata.
6. L’imputato C.F. ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, deducendo due motivi.
6.1. Con il primo, ha dedotto vizio di mancanza della motivazione con riferimento all’art. 589 co. 2 cod. pen., osservando che la Corte territoriale avrebbe capovolto gli esiti del giudizio assolutorio, sulla scorta dello stesso materiale probatorio, dando ad esso una diversa lettura e senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, in violazione dei principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Dasgupta del 2016.
6.2. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 157 comma 6 e 589 co. 2 cod. pen., rilevando l’erroneità del calcolo della prescrizione da parte del giudice dell’appello, atteso che il raddoppio dei relativi termini per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica è stato introdotto dall’art. 6 co. 1 della legge 251 del 2005, successivamente, quindi, ai fatti per cui si procede, e che solo con la legge 125/08 il limite massimo di pena per il reato contestato è stato innalzato da 5 a 7 anni di reclusione. Con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe spirato ancor prima della conclusione del dibattimento di primo grado, calcolato il termine di anni sei, l’aumento del quarto e i periodi di sospensione.
Diritto:
1. Il ricorso dell’imputato R.G. è inammissibile.
Va, intanto, premesso che le doglianze si risolvono sostanzialmente in una diversa lettura del materiale probatorio, analiticamente esaminato nei due gradi di giudizio di merito, debitamente valutati i motivi del gravame da parte della Corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo che, siccome congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze probatorie, è sottratto al vaglio di legittimità.
2. Alla luce di tale premessa, devono pertanto ritenersi manifestamente infondati i primi tre motivi, nella parte in cui con gli stessi si è inteso contestare, attraverso una diversa lettura delle prove, l’esistenza del contratto di appalto tra la società del R.G. e il C.F. e quella del rapporto di lavoro tra la predetta società e il B.A., rilevandosi peraltro l’inconducenza della riconosciuta inesistenza, da parte del giudice del lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato tra questi ultimi soggetti.
2.1. Sotto tale profilo, in via generale, deve ritenersi sussistente l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale (cfr. sez. 7 n. 11487 del 19/02/2016, Rv. 266129), altresì rilevandosi che la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro” (cfr. sez. 4 n. 7730 del 16/01/2008, Rv. 238757).
Peraltro, si è pure ritenuto che l’assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell’esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l’instaurazione di fatto (cfr. sez. 4 n. 8589 del 14/01/2008, Rv. 238966), altresì osservandosi che un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (cfr. sez. 4 n. 12348 del 29/01/2008, Rv. 239251, in fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).
2.2. Infine, quanto alla contraddizione della decisione impugnata che la difesa pretende di ravvisare nel presunto riconoscimento, in capo all’imputato R.G., della doppia veste di datore di lavoro e coordinatore per l’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, trattasi di argomentazione al più suggestiva che, facendo leva sull’utilizzo del termine coordinatore, dimentica del tutto però il contenuto del capo d’imputazione, interamente calibrato sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro, con riferimento ad un cantiere nel quale peraltro non è stata neppure ipotizzata l’esistenza della figura, diversa da quella del datore di lavoro, i cui compiti specifici sono descritti nell’art. 5 del d.lgs. 494/96, né la violazione di un obbligo ai sensi dell’art. 3 co. 4 del d.lgs. 494/96 in capo alla diversa figura del committente, cui spetta di nominare, in determinate ipotesi, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale, come è stato anche di recente affermato, oltre ad essere titolare dei compiti affidati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale (cfr. sez. 4 n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735).
Secondo il tenore dell’accusa, infatti, il R.G. sarebbe stato il coordinatore di fatto delle opere oggetto dell’appalto, espressione da intendersi riferita, in mancanza di indicazioni espressamente riconducibili ai compiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 494/96, alla circostanza che era stato proprio l’imputato a gestire quell’appalto in ambito societario, come del resto è emerso dall’istuttoria ed è stato ben evidenziato dai giudici del merito nelle due decisioni conformi.
2.3. Sul punto, va pure rilevato che – ai fini dell’individuazione delle posizioni di garanzia – qualora nell’impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l’accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all’intemo della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato [cfr. sez. 4 n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004), Rv. 229671].
3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo entrambi i giudici del merito fatto riferimento alla gravità della condotta negligente, quanto al Tribunale correttamente evidenziando la mancata allegazione di elementi positivi, oltre alla sola incensuratezza, alla luce dei quali addivenire ad una pena più mite, quello d’appello avendo ritenuto invece di dover mitigare la stessa, bilanciando gli elementi circostanziali in termini di equivalenza, evidenziandosi, peraltro, profili di aspecificità del motivo di ricorso, per avere la parte affidato la propria doglianza a elementi del tutto astratti (vita anteatta, affidamento non irragionevole anche sulle altrui attività, peculiari ragioni e circostanze in cui il fatto è maturato), senza indicare le specifiche circostanze del caso concreto, eventualmente pretermesse dal giudice in punto dosimetria della pena in concreto inflitta.
4. Il ricorso presentato nell’interesse dell’Imputato C.F. va rigettato.
Secondo il capo d’imputazione, la responsabilità dell’imputato ha riguardato la sua posizione di committente delle opere, durante l’esecuzione delle quali ha perso la vita il lavoratore B.A.. A fronte di tale contestazione, il Tribunale di Catania ha escluso la sua responsabilità, per avere assunto il R.G. pieno ed esclusivo titolo in ordine alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto del capannone, di proprietà del C.F.. In particolare, secondo il ragionamento svolto, configurandosi un contratto di appalto tra la COMAED s.r.l. e il C.F. e non essendovi prova che quest’ultimo si fosse ingerito nella organizzazione del lavoro, doveva escludersi che costui avesse rivestito una posizione di garanzia, con obblighi di controllo sulla sicurezza del cantiere, di ingerenza nel processo lavorativo e di verifica delle concrete modalità di esecuzione dei lavori e direzione del cantiere, in difetto di elementi tali da fargli ritenere l’assenza della capacità tecnica e professionale dell’appaltatore, trattandosi di società professionalmente dedita all’esecuzione di lavori del tipo di quelli commissionati dal C.F..
Il verdetto assolutorio è stato ribaltato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato che, in materia di infortuni sul lavoro, il committente deve ritenersi soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza in base all’art. 6 del d.lgs. 494/96 e che, in base all’art. 7 co. 2 del d.lgs. 626/94, nel caso di datori di lavoro che affidino lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, costoro sono destinatari di specifici obblighi finalizzati ad attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi, ai quali sono esposti i lavoratori, eccezion fatta per quelli specifici, propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la configurabilità di un rischio specifico, stante la genericità dell’obbligo di impedire cadute dall’alto da parte di chi esegue lavori in quota, pericolo di per sé riconoscibile indipendentemente da specifiche competenze tecniche. Ha poi affermato che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e che le violazioni poste in essere, nel caso in esame, non riguardavano condotte imprevedibili, estemporanee ed occasionali, attenendo alla organizzazione del cantiere ed alla preventiva predisposizione di indispensabili cautele per la sicurezza dei lavoratori, pienamente rientranti nella sfera di controllo dell’imputato. Alla stregua del ragionamento contro fattuale, inoltre, quel giudice ha rilevato che – ove l’imputato avesse posto in essere la condotta doverosa imposta, vigilando cioè sulla adozione delle misure precauzionali – avrebbe neutralizzato il rischio connesso all’attività lavorativa in concreto espletata e scongiurato l’evento poi verificatosi.
Secondo il giudice del gravame, sarebbero quindi ravvisabili una culpa in eligendo, non avendo il C.F. preliminarmente verificato la idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice che aveva gestito l’appalto senza adottare le pur minime misure precauzionali, ingaggiando un lavoratore che non era neppure dipendente di detta società, senza provvedere alla sua informazione e formazione, ma anche una culpa in vigilando, a fronte di un rischio caduta che è quello principale tipico per chi svolge lavori in quota, riconoscibile dal committente dei lavori, sempre presente in cantiere, in grado di accorgersi della assenza delle misure di sicurezza e titolare di un potere inibitorio dei lavori.
4.1. Il primo motivo è infondato.
Il caso di specie, nel quale il giudice d’appello, accogliendo il gravame del Procuratore Generale, ha ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado nei confronti dell’imputato, si pone nel solco delle pronunce che impongono una verifica della base fattuale sulla quale è intervenuta la decisione della Corte territoriale, non disgiunta da uno scrutinio circa l’eventuale violazione del diritto dell’imputato di essere giudicato ad esito di un processo equo, nel quale il materiale probatorio esaminato dai diversi giudici del merito non abbia costituito oggetto di una valutazione distonica rispetto ai principi che costituiscono ormai ius receptum a seguito della nota decisione della Corte E.D.U. nel caso Dan contro Moldavia [ma che, in realtà, trova espressione già in precedenti pronunce, a partire dal caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, nei casi Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurbor Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c. Spagna del 21/01/2006 (cfr., per tali richiami, motivazione sent. Sezioni Unite n. 27620 del 2016, Dasgupta)].
4.2. L’argomento, come è evidente, chiama in causa innanzitutto i principi che questa Corte ha gà da tempo elaborato in tema di motivazione rafforzata. Infatti, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229).
Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell’08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 deN’11/07/2012, Rv. 254617].
Ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, potendo il verdetto di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in prima cura [cfr. sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013 ud. (dep. 14/03/2014), Rv. 262261; sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718].
4.3. Il tema coinvolge anche quello della corretta interpretazione del canone del “ragionevole dubbio”, quale limite alla riforma di una sentenza assolutoria, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (nella già citata sentenza del 2016, Dasgupta) rilevato che <<per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. adopera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, accorrendo una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio” (ex plurimis, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718); posto che, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».
Inoltre, nel caso specifico in cui la reformatio in peius sia frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative, all’indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, si è chiarito che il giudice ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Tale principio è stato interpretato in maniera non assoluta, essendosi di volta in volta ravvisati alcuni contemperamenti, per esempio nel caso in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall’accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria (cfr. sez. 5 n. 29827 del 2015 e sez. 6 citata 44084 del 2014 citate), oppure nel caso in cui ad essere rivalutata sia l’attendibilità estrinseca delle prove orali, cioè la ravvisabilità nel compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma (cfr. sez. 6 n. 47722 del 06710/2015, Rv. 265879), ovvero quando il giudice d’appello fondi il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio (cfr. sez. 3 n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124) e sempre che dette prove siano decisive per l’affermazione di resposnabilità (cfr. sez. 5 n. 25475 del 24/02/2015, Rv. 263903), in altre ipotesi essendosi invece addirittura affermato che l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria in appello, in caso di diversa valutazione dell’attendibilità dei soggetti da cui promani la prova dichiarativa, siccome espressione del principio generale di immediatezza, conformemente all’art. 6 della Convenzione E.D.U. così come intepretato dalla Corte di Strasburgo, trova applicazione non solo quando il giudice d’appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell’ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado, essendosi precisato che detto obbligo è ancor più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile (cfr. Sez. 2 n. 32619 del 24/04/2014, Rv. 260071).
Il tema ha, peraltro, costituito oggetto di una complessiva rivisitazione, anche a fronte di talune divergenti interpretazioni delle sezioni semplici di questa Corte, proprio da parte delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 27620 del 2016, Dasgupta, citata), chiamate a risolvere la questione della rilevabilità d’ufficio – in sede di giudizio di cassazione – della violazione dell’art. 6 CEDU per avere il giudice d’appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi.
In quella sede, il Supremo Collegio ha intanto chiarito che la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante (cfr. sent, citata Rv. 267488), altresì affermando che la previsione contenuta nell’art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU (il richiamo, in motivazione, è alle sentenze della Corte E.D.U. in Manolachi c/Romania del 05/03/2013 e Flueras c/Romania del 09/04/2013) – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (cfr. sent. citata Rv. 267487), sgombrando il campo anche dai dubbi rinvenibili nelle decisioni rese da questa Corte a proposito della operatività di tali principi nel caso di riforma ai soli effetti civili (cfr. sent. citata Rv. 267489).
Cosicché deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’alt. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (cfr. sent. citata Rv. 267492).
La sentenza in commento si fa carico di specificare quali siano le prove decisive al fine della necessità di procedere ex art. 603 cod. proc. pen., offrendo taluni spunti di riflessione certamente utili ai fini che ci occupano.
Si è infatti riconosciuta detta natura alle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché a quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (cfr. citata sentenza Rv. 267491).
A fronte di tale quadro ricostruttivo dei principi sottesi al processo penale, si è poi precisato da parte del Supremo Collegio, nella più volte citata sentenza Dasgupta del 2016, che <<dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale>> e che <<la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come “assolutamente necessaria” ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale presupposto, infatti, ai di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del “ragionevole dubbio”, replichi l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte>>, non potendosi, pertanto, ritenere “decisivo” un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell’affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944)>> e neppure <<può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall’appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).
4.4. Tale premessa, necessaria ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie all’esame, che tenga conto dei principi sopra diffusamente richiamati, consente di escludere che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza censurata sia incorsa nei profili di illegittimità allegati.
Infatti, la sentenza di condanna censurata non costituisce il precipitato di un percorso argomentativo che, sulla scorta di una rivalutazione delle prove orali decisive esaminate dal Tribunale e della loro attendibilità, abbia ad esse dato una diversa lettura. Il giudice d’appello, infatti, ha dato alle prove il medesimo significato assegnato dal Tribunale e si è limitato a rettificare un errore di diritto nel quale è incorso il primo giudice con riferimento all’inquadramento della posizione giuridica ricoperta dal C.F., nella qualità – accertata e non contestata – di committente dell’opera.
A tale accertata qualità, infatti, il Tribunale, con un ragionamento tanto laconico quanto apodittico, ha ritenuto che non fosse ricollegabile alcuna posizione di garanzia, a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e, quindi, alcun obbligo giuridico la cui violazione può divenire fonte di penale responsabilità, ove eziologicamente collegata all’evento prodottosi, alla luce della mancata ingerenza del committente nell’organizzazione del lavoro.
Si tratta, in buona sostanza, di un’operazione concettuale necessariamente antecedente alla verifica, in concreto, della sussistenza di profili di rimprovero per colpa e del giudizio controfattuale rispetto alla condotta omessa.
Il dovere di motivazione rafforzata, peraltro, deve ritenersi debitamente assolto in un caso, come quello di specie, in cui al giudice d’appello sia toccato di ricostruire la fattispecie, sulla scorta di dati fattuali certi, valutati negli stessi termini dal giudice di primo grado, ma facendo applicazione delle norme di settore, del tutto pretermesse dal Tribunale.
Non può pertanto ravvisarsi nella sentenza censurata alcun vizio di legittimità che derivi dalla violazione dei principi dell’immediatezza e dell’oralità della prova e del ragionevole dubbio, né un dissenso rispetto alla attendibilità dei dichiaranti e al contenuto delle prove orali acquisite in primo grado, dovendosi fissare il principio di diritto secondo cui, in caso di condanna in appello, il giudice assolve correttamente all’obbligo di motivazione rafforzata, senza incorrere in violazione del principio del ragionevole dubbio, ove la conadnna sia la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell’assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice.
4.5. Quanto all’inquadramento giuridico della posizione ricoperta dall’imputato C.F., il confronto tra le due motivazioni è reso assai agevole dalla notevole stringatezza della sentenza appellata, con la quale, in definitiva, il Tribunale è pervenuto alla assoluzione del committente dei lavori, sulla scorta delle seguenti considerazioni: il R.G. ha assunto il pieno ed esclusivo titolo della realizzazione dei lavori; il C.F. e il R.G. hanno stipulato un contratto di appalto per la loro esecuzione; il primo non si è ingerito nella organizzazione dei lavori; non vi sono elementi per dubitare della capacità professionale della ditta appaltatrice e, quindi, non sussiste alcun obbligo di ingerenza del C.F. nel processo lavorativo e di verifica delle concrete modalità di esecuzione dei lavori e di svolgimento del compito di direzione del cantiere.
Tali considerazioni non si confrontano con la specifica posizione di garanzia che la legge (anche quella in vigore all’epoca dei fatti) riconosce in capo al committente di un’opera. Pur dando per provata l’esistenza del contratto di appalto tra i due imputati, e così le diverse sfere di responsabilità astrattamente ricononducibili alle due distinte e concorrenti posizioni di garanzia, il Tribunale non ha tenuto conto dei rispettivi obblighi di salvaguardia rispetto alla sicurezza del cantiere, pretendendo di escludere quelli direttamente incombenti sul committente in virtù di un accollo integrale da parte di un soggetto che riveste, tuttavia, una differente posizione di garanzia (il R.G.).
In sostanza, nella prospettiva del primo giudice, il committente non avrebbe rivestito una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore, posizione ravvisabile solo ove egli l’avesse in concreto assunta, ingerendosi di fatto nella esecuzione dei lavori, in virtù del principio di effettività da sempre riconosciuto operante in tale materia. Tale ricostruzione si pone tuttavia in contrasto con la normativa di settore a partire dal d.lgs. 494 del 1996 di attuazione della direttiva 92/57/CEE, con la quale la figura del committente ha trovato espressa definizione (cfr. art. 2 co. 1 lett. b), con esplicitazione anche degli obblighi autonomamente gravanti sul medesimo (art. 3).
Sul punto, basti ricordare quanto già affermato da questa stessa sezione in ordine al contenuto di tale posizione di garanzia, allorché si è precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr. sez. 4 n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).
La Corte del merito ha correttamente ricostruito la condotta colposa del committente C.F., sia con riferimento alla scelta della ditta appaltatrice, tenuto conto degli obblighi di verifica imposti dall’art. 3 co. 8 del d lgs. 494/96, che sulla scorta dell’omesso controllo dell’adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel caso di specie totalmente omesse. Tali misure non devono essere approntate dal committente, rientrando certamente nel novero degli obblighi propri del datore di lavoro, ma la loro concreta adozione da parte di costui deve essere verificata e, in caso di accertata omissione, pretesa dal committente.
L’obbligo di verifica riconducibile al committente non si è tradotto, nel caso di specie, in un inammissibile dovere di controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, che la legge non individua, né in un rimprovero per la violazione di obblighi che fanno capo ad altra figura di garante legale. Esso è stato delimitato e calibrato in base alla capacità di governo della fonte di pericolo da parte del soggetto portatore dell’interesse primario alla realizzazione dell’opera, che ha messo cioè in moto l’attività in cui si è concretizzata l’esposizione a rischio della vittima. Ed infatti, anche se l’inidoneità dell’impresa non può farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuto infortunio, questa sezione ha già chiarito che “…il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati…”, pur essendosi precisato, con riferimento alla verifica di una culpa in eligendo, che essa deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4 n. 44131 del 2015 citata), onere assolto, nel caso di specie, dalla Corte di merito.
Il committente, quale quello che, come nel caso di specie, affidi i lavori ad un’unica impresa, concorre, in definitiva, unitamente alle altre figure di garanti legalmente individuati, ognuno con precisi doveri, differentemente declinati dal legislatore, alla gestione del rischio connesso alla realizzazione di un’opera che ha specifiche caratteristiche ed è a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore e, pertanto, vero dominus di essa, titolare di poteri di inibizione, la mancata attivazione dei quali, nel caso di specie, ha consentito la prosecuzione dei lavori in totale difformità alle norme più elementari poste a presidio dell’incolumità dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera stessa, ponendosi in rapporto di causa-effetto con il decesso del lavoratore B.A..
Infine, va pure rilevato con riferimento alla terza osservazione difensiva, sopra richiamata, che la stessa è stata solo apoditticamente affermata e non tiene in alcun conto la natura del rischio (generico) di caduta dall’alto per i lavori da svolgersi in quota.
4.6. Anche il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello di Catania ha escluso l’effetto estintivo della prescrizione, tenuto conto del termine minimo di anni sei e del raddoppio di cui all’art. 157 co. 6 cod. pen., stante il titolo di reato, calcolati altresì l’aumento del quarto (anni tre) di cui all’art. 161 cod. pen. e i periodi di sospensione per complessivi mesi 11 e giorni 25 e per ulteriori giorni 17.
4.7. Occorre intanto chiarire i termini giuridici della questione prospettata dalla difesa.
L’art. 157 cod. pen., in vigore all’epoca del fatto, prevedeva il termine di anni quindici per la prescrizione dei delitti per i quali era prevista una pena della reclusione non inferiore a dieci anni; lo stesso articolo, novellato dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) prevede, invece, che la prescrizione estingue il reato quando è decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore ad anni sei in caso di delitto, con raddoppio per talune ipotesi di reato (tra cui quello all’esame) e un aumento massimo del quarto in caso di sospensione ed interruzione ai sensi dell’art. 161 co. 2 cod. pen.
Quanto al regime transitorio, esso è disciplinato dall’art. 10 della suindicata legge n. 251/05 che ha espressamente stabilito al comma 2 che <<…ferme restando le disposizione dell’art. 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti>> e al comma 3 che <<se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione>>.
La pena per il reato di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen., vigente al momento del fatto era quella della reclusione da due a cinque anni, limite massimo edittale successivamente elevato ad anni sette, in forza della novella di cui all’art. 1 co. 1 lett. c) n. 1 d.l. 92/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008.
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione della normativa sul regime della prescrizione più favorevole al reo, non si può procedere a una combinazione delle norme previgenti con quelle successive introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovendo in ogni caso farsi riferimento anche alle disposizioni in tema di continuazione tra reati e di modalità di computo del termine da cui far decorrere la prescrizione (cfr.sez. 5 n. 48743 del 29/10/2014, Rv. 261300; n. 29698 del 25/05/2016, Rv. 267386; n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228; n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783).
Ciò posto, il termine di prescrizione del reato, ferma restando l’individuazione della pena massima edittale (anni cinque di reclusione, stante il giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche, come da dispositivo letto all’udienza del 20 maggio 2016) nella misura antecedente alla modifica di cui alla legge 125/08, è il medesimo sia in base al regime vigente anteriormente alla legge c.d. ex Cirielli, per il quale andrebbe individuato in anni quindici, sia in base alla nuova normativa, per la quale detto termine sarebbe quello di anni sei, da raddoppiarsi tuttavia ex art. 157 co. 6 cod. pen., oltre all’aumento del quarto ex art. 151 cod. pen. e, quindi, ancora una volta, quello di anni 15 (esclusi i periodi di sospensione).
5. Alla decisione segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché del solo R.G. anche al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.:
Dichiara inammissibile il ricorso di R.G. e rigetta quello di C.F. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il R.G. al versamento della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2017.
FONTE: Cassazione Penale
- Condividi con i tuoi amici!